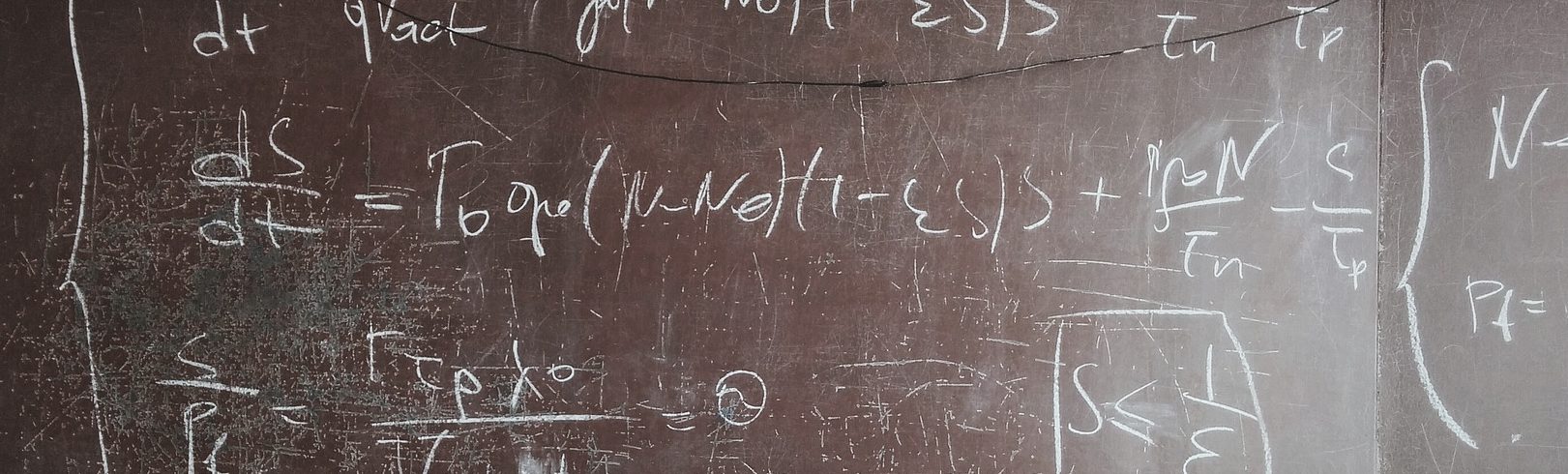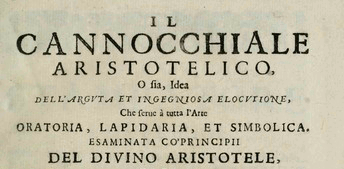
Retorica
Nella scuola secondaria la retorica è stata vista piú come strumento formale e apparato esterno alla rete dei significati, piuttosto che principio organizzatore del discorso e del processo argomentativo. In questo senso è venuta meno una risorsa molto interessante per quanto riguarda l’apprendimento delle tecniche di scrittura, che andrebbe ovviamente ripresa seppur con modalità piú originali e creative. Il linguaggio della pubblicità e poi internet sono un bacino peraltro sterminato, da verificare in chiave didattica, per una ricognizione sulle pratiche della retorica, sui molti stili di scrittura che si presentano sul web e che possono offrire all’insegnante occasioni di esercitazione, decostruzione-riproduzione, analisi, commento: dai blog alle testate giornalistiche, dai siti educational alle pratiche di storytelling, alle webquest. La riconsiderazione delle molteplici sfumature dell’armamentario retorico dei testi – dai classici agli enunciati di uso comune, alle opere letterarie – non rappresenta affatto una posizione di retroguardia: semmai sta a significare il cambio di un paradigma, uno su tutti il legame in termini qualitativi che c’è tra comunicazione e informazione e che si presenta in una sorta di ibridazione della scrittura con le forme dell’oralità, con i modi della leggerezza, della rapidità, della molteplicità (Rosati - Venier: 2005).
Vediamo uno scenario possibile. In una celebre pagina de Il nome della rosa, Umberto Eco fa visitare al giovane Adso da Melk lo scriptorium dell’abbazia in cui si svolge l’azione, peraltro rispettando le unità aristoteliche di tempo e di spazio: in questo luogo di sapienza, il novizio benedettino incontra molti monaci impegnati a ricopiare, tradurre, miniare, glossare i preziosi codici. Si potrebbe chiosare in stile citazionista – in questo Eco è maestro – che “il catalogo è questo”: il brano è infatti un lungo elenco. “Conobbi cosí Venanzio da Salvemec, traduttore dal greco e dall’arabo, devoto di quell’Aristotele che certamente fu il piú saggio di tutti gli uomini. Bencio da Upsala, un giovane monaco scandinavo che si occupava di retorica. Berengario da Arundel, l’aiuto del bibliotecario. Aymaro da Alessandria, che stava ricopiando opere che solo per pochi mesi sarebbero state in prestito alla biblioteca, e poi un gruppo di miniatori di vari paesi, Patrizio da Clonmacnois, Rabano da Toledo, Magnus da Iona, Waldo da Hereford. L’elenco potrebbe certo continuare e nulla vi è di piú meraviglioso dell’elenco, strumento di mirabili ipotiposi” (Eco: 1980, 81). Ecco: l’ipotiposi, una figura della descrizione, uno dei tropi che appartengono alla famiglia della ékphrasis, diviene strumento di comprensione di una situazione pragmatica, di interpretazione di un evento occasionale. Charles Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca nel Trattato dell’argomentazione impiegano l’ipotiposi (demonstratio) per sottolineare in che cosa e come l’uso di alcune figure determinate si spieghi con i bisogni dell’argomentazione. E allora riprendono la definizione della Retorica a Erennio (IV, 68) e della Institutio quintilianea (IX, 2, 40) dove l’ipotiposi di Eco è quella figura “che espone le cose in modo tale, che il fatto sembra svolgersi e la cosa avvenire sotto gli occhi dei presenti” (Perelman - Olbrechts-Tyteca: 1989, 177). Le applicazioni sul terreno della didattica sarebbero moltissime, utili tra l’altro all’apprendimento delle tecniche della scrittura. Descrivere un avvenimento, una scena rispettando il rapporto tra i tempi dell’evento e quelli della sua rappresentazione, in modo che il primo corrisponda ai tempi della lettura (Joyce in alcuni capitoli di Ulysses, ad esempio); oppure rappresentare ciò che avviene davanti agli occhi di un viaggiatore, facendo percepire al lettore ciò che vede il protagonista, come accade nel racconto La steppa di Cechov, dove il piccolo Egoruška ci racconta la sterminata pianura russa nelle sue fattezze e nella sua malinconia. Il senso della vista nella narrazione non è un elemento trascurabile: è anzi un tratto dominante di molta parte del romanzo, e di quello ottocentesco in particolare. “C’è una storia della visività romanzesca – scrive Calvino a proposito di Flaubert – del romanzo come arte di far vedere persone e cose, che coincide con alcuni momenti della storia del romanzo, ma non con tutti. Da Madame de Lafayette a Constant il romanzo esplora l’animo umano con un’acutezza prodigiosa, ma le pagine sono come persiane chiuse che non lasciano vedere niente. La visività romanzesca comincia con Stendhal e Balzac, e tocca con Flaubert il rapporto perfetto fra parola e immagine (il massimo d’economia col massimo rendimento). La crisi della visività romanzesca comincerà mezzo secolo dopo, contemporaneamente all’avvento del cinema” (Calvino: 1995 - I, 850-851). La visività della scrittura, della narrazione in generale, è una retorica dominante in molte delle stagioni del romanzo, in particolare di quello ottocentesco: ma è mutevole riguardo al punto di osservazione e alla composizione scenica, di tipo drammaturgico e incline alla pittura (in Manzoni, ad esempio); fotografica e documentaria nelle pagine del roman expérimental di Zola.
Quale retorica, allora, che sia valida per l’argomentazione e per un uso produttivo in classe, cioè come modalità di lettura, comprensione, interpretazione e riscrittura del testo? Ora che l’ars oratoria e le artes dictandi fossero tra le attrezzature fondamentali nella formazione del clericus medievale è cosa largamente conosciuta, e non è questo il caso per approfondire una materia su cui è già stato scritto quasi tutto. Il fatto che ci interessa riguarda invece l’utilizzo che della retorica è stato fatto a latere dell’educazione letteraria nella scuola secondaria. Da sempre ricondotta entro l’alveo della grammatica, dell’educazione linguistica e della narratologia, la retorica si è ricomposta come prospettiva globalizzante (Mortara Garavelli: 2011, 29) nelle “neoretoriche” di provenienza strutturalista e post-strutturalista; ha assunto la veste di una semiotica del discorso (Genette) e di una poetica del testo (Lotman). Tuttavia nella scuola la retorica ha coinciso quasi esclusivamente con l’elocutio, cioè con il catalogo delle figure retoriche e quindi con il nozionismo astratto delle definizioni attuato attraverso la diffusione di glossari e dizionari ad hoc – opportunamente collocati in appendice ai libri di testo – che però non hanno contribuito ad insegnare le tecniche di costruzione del discorso né a potenziare le competenze argomentative. Al contrario alcune esperienze particolarmente illuminanti (Lo Cascio: 1991; Mortara Garavelli: 1993 e 2011; Eco: 2009) dimostrano che è possibile avviare percorsi didattici di analisi del testo, di confronto tra l’opera letteraria e quella figurativa e di lettura interdisciplinare impiegando la retorica non solo “in estensione, ma anche in profondità” e dunque non in quanto “blocco disciplinare e catalogo, ma come sterminato inventario di meccanismi della discorsività che alla base configurano un’immagine problematica del soggetto che prende la parola” (Caffi: 2001, 148).
La discussione sui pericoli che minacciano la cultura umanistica – e la retorica in quanto impalcatura del sapere letterario è una delle componenti piú in vista del conservatorismo delle humanae litterae – risulta di grande attualità nel panorama di una scuola smarrita e impaurita davanti alla preponderanza delle tecnologie, al declino della lettura, alla perdita di credibilità e di autorevolezza delle principali istituzioni educative. Per certi versi al ripiegamento dei saperi letterari non ha corrisposto nella scuola nemmeno una ripresa o una ritrovata egemonia di quelli scientifici: la vecchia querelle sulle “due culture”, argomento che fu al centro di un libro bellissimo di Giulio Preti, rischia pertanto di essere inadeguata dinanzi alla terza fase e va quindi “ricurvata”, riadattata entro certi limiti, alle sfide che vedono in campo una nuova immagine della scienza. Se appare tramontato il modello di una scienza della necessità, di origine positivistica e votata a un’idea di progresso lineare, capace “di qualificare in termini positivi il processo storico” (Bury: 1964, 5), neanche l’immagine di una scienza della probabilità, di chiara ascendenza primonovecentesca – freudiana prima, e einsteiniana poi – sembra capace di sintetizzare l’orientamento dell’epistemologia moderna, che è oggi sempre piú complessa e mischiata con i dati e le categorie dell’umanesimo e con le conseguenze sui soggetti in formazione, con le sfide dell’economia globale, con i dilemmi etici prospettati dalla genetica e dalle neuroscienze. Questa “sfida della complessità” – teorizzata negli anni ottanta del secolo scorso – si impone sul terreno pedagogico ed educativo come un “richiamo antiriduzionistico, come un fattore di interpretazione della formazione e dei suoi processi, come la salvaguardia della specificità strutturale di tali processi” (Cambi: 2005, 21).
Retorica e logica sono dunque da considerare ancora come i due poli di quella struttura fenomenologica della civiltà moderna? E da qui, si può realmente pensare una società della conoscenza che sia fatta di una sostanza bipolare, scomposta e separata, in cui i valori della humanitas e quelli della cultura scientifica procedano davvero separati, inconciliabili, senza possibilità di comunicazione? Il discorso scientifico e la sua argomentazione non sono forse costituiti di retorica, di logiche dimostrative, di esigenze comunicative che trovano sbocco nel linguaggio? E la letteratura, con il romanzo soprattutto, non dialoga forse – dall’età moderna in avanti – con le trasformazioni e i contributi della scienza? Si pensi al rapporto tra Galilei e la divulgazione scientifica che egli condusse nel Dialogo dei massimi sistemi e nel Saggiatore, oppure – con echi blumenberghiani – all’immagine della leggibilità della natura e del mondo (Blumenberg: 1984 e 1987); si pensi alla querelle illuminista di Alessandro Verri sulla necessità di aggiornare la tradizione aulica e cruscante con un nuovo lessico che in parte era il risultato della rivoluzione scientifica e tecnica del razionalismo settecentesco; e ancora al rapporto tra il romanzo a tesi del naturalismo francese e l’evoluzionismo darwiniano; ai temi della bioetica, delle neuroscienze, della clonazione, del mondo digitale: indiscussi protagonisti di molti dei romanzi mondo degli ultimi anni.
Ma è ancora il coinvolgimento didattico della retorica che merita qualche ulteriore chiarimento: sulla sua funzione di snodo e di ponte tra la grammatica e la letteratura, tra la norma della lingua scritta e i suoi elementi stilistici, tra la forma e la sostanza di una pragmatica dell’insegnamento letterario. Una complessa architettura del discorso retorico – in vista della fondazione di una nouvelle rhétorique – era stata a suo tempo avanzata da Perelman e dalla Olbrechts-Tyteca nel loro Traité de l’argumentation con l’intento di sanare il divario storico tra le due culture, attribuendo anche alle scienze umane “un loro grado di tecnicità, anche se dovrà essere una tecnica ‘aperta’, del fluido e del variabile” (Barilli: 1983, 130). Il merito, e il successo, del Traité è stato senz’altro quello di aver ricondotto l’attenzione soprattutto su inventio e dispositio come strutture-base del discorso argomentativo e dimostrativo da cui passa tutta la costruzione dell’enunciato. Quale destino, allora, per l’elocutio, per le figure retoriche su cui la scuola si è esercitata in una nominazione-definizione nozionistica, peraltro finalizzata ad un loro semplice riconoscimento all’interno dei testi? Se la premessa è una “retorica concepita come arte di parlare e di scrivere bene, come tecnica di espressione del pensiero, come pura forma” la conseguenza che viene indicata da Perelman è il netto rifiuto di quel verbalismo in quanto esso costringerebbe a “separare, nel discorso, la forma dal fondamento, di studiare le strutture e le figure stilistiche indipendentemente dallo scopo cui esse soddisfano nell’argomentazione” (Perelman - Olbrechts-Tyteca: 1989, 150).
Nel “rovescio dei segni” la retorica diviene essa stessa un sistema semiologico, e il suo universo è popolato di figure, di tropi, di metafore: questi slittamenti di significato allargano a dismisura le ambiguità del testo e determinano l’apparato dei significati complessi che è poi il fine ultimo della comprensione. È qui che la forma si ricongiunge con i contenuti, nel momento in cui le metafore prendono “sostanza di insieme” e compongono l’immaginario dei tópoi, degli archetipi, delle idee-forma del testo in quanto dimensioni formative attraverso il testo.
Vero e proprio arsenale dell’immaginario, i tópoi sono alla base non solo dell’argomentazione, ma dello stesso impianto complessivo della retorica: essi innervano di contenuto e di significato il testo letterario di cui costituiscono al tempo stesso la sintesi e il tema dominante, il motivo di fondo e il paradigma interpretativo. In tale densa archetipologia la nozione di τóπος ha poi subíto una traslazione e un’estensione di significato dall’iniziale natura argomentativa. “Nell’uso dei concetti di tema, τóπος, motivo – scrive Giovanni Pozzi – si passa dall’idea di elementi contenutistici all’idea di elementi formali; dall’idea di costante all’idea di mutazione ed evoluzione; dall’idea di entità polisemica all’idea di entità asemica; dall’idea di calco all’idea di archetipo. In ciascun dato si osservano cose diversissime: polivalenza semantica di un concetto, forme simboliche figurali o verbali, convenzioni linguistiche e sociali dei modi di comunicazione; pratiche della persuasione, tecniche della memoria, moduli stilistici intenzionali. Il τóπος viene pensato a volte come una costante atemporale, soggetto solo a variazioni stilistiche, a volte come un’invariante ontologica, antropologica, psicanalitica; e, nella sua varianza, ora alla stregua d’una biologia della letteratura, ora alla stregua d’una successione di fasi individuali” (Pozzi: 1984, 393). In un lavoro sul testo il riconoscimento semantico dei contenuti narrativi potrebbe consentire la distinzione/opposizione tra tema e motivo in quanto entità distinte a livello funzionale: mentre il motivo è infatti “un’unità concreta del contenuto, facile da circoscrivere, e spesso designata attraverso un sintagma che già contiene in nuce l’articolazione narrativa” (Bertoni - Fusillo: 2003, 32), il tema appare piú legato alla soggettività di chi legge e interpreta diventando di fatto uno “spazio di tensione” fra l’argomento di un’opera e il suo senso piú generale. Ma è del resto evidente che sotto il profilo strettamente pedagogico la comprensione del nesso tema-motivo e il lavoro inferenziale sul testo potrebbero offrire un ventaglio molto ampio di opzioni per decostruire la testualità delle opere narrative, dell’epos, della testualità filmica (Giglioli: 2001).
Dunque, dalla retorica i tópoi passano nel contenitore di una tematica universale e nella metaforologia e diventano oggetto di leggibilità, di interpretazione: quei loci communes orientano le cattedrali di senso della letteratura europea e occidentale che si snoda attorno alle grandi famiglie di immagini che dal medioevo salgono fino all’età moderna e contemporanea. I luoghi comuni e le metafore – cosí bene rappresentati da Curtius e Blumenberg nei loro risvolti trasversali – sono un apparato di irradiazione delle idee che compongono la realtà; forme originarie per interpretare il mondo, per collocarsi e disporsi soggettivamente dentro questo sistema; canali di trasmissione di immagini ricorrenti e variabili, per loro natura dotate di un forte impatto emotivo e formativo proprio perché paradigmatiche del nostro essere nel mondo.
La filologia tematica e comparatistica di Curtius (1992) e la paradigmatica delle metafore di Blumenberg (1969; 1984) vanno a costruire una Bildung letteraria europea, transnazionale nella geografia degli spazi letterari; diacronica e genealogica nella sua evoluzione storica; scomponibile, combinatoria, riaggregabile nei modi di approccio, di fruizione e di leggibilità. La lettura di tali immagini infatti non potrà che essere una lettura ermeneutica, interpretativa di quella sillabazione e scomposizione del mondo in tante realtà che si manifestano in forme intellegibili “al di là delle apparenze dei sensi e al di qua di una spiegazione completa ed esaustiva” (Blumenberg: 1984, X). Le figure dell’immaginario operano in direzione di itinerari multiformi, agiscono in quanto strutture di longue durée, attraverso i generi, gli schemi e i metri letterari: rappresentano cioè quella “frontiera avanzata” della formazione ai dispositivi narrativi esattamente per gli effetti continuati della loro natura esemplare e modellizzante. La letteratura, dunque, categorizza i temi, le figure, gli emblemi e le strutture dell’immaginario. Ed è attraverso questa capacità di innalzare le situazioni del quotidiano a modelli riproducibili, a condizioni e realtà ancora possibili – talvolta ineluttabili – dell’agire umano, che la letteratura incide nella costruzione dell’identità. Come? Ad esempio grazie all’identificazione, al rispecchiamento del soggetto in quelle categorie, in quelle situazioni narrative: ecco perché sono fondamentali il romanzo e la sua comprensione interiore.
Ma l’immaginario non è solo il luogo in cui mito e letteratura convivono: è anche quello in cui avvengono la trasformazione e lo slittamento dei macrosegni letterari. L’immaginario unisce, stringe legami, ricuce la letterarietà e l’ideologia, riassorbe le forme e le accomuna con i generi: piú che dividere, esso connette le costanti, la ricorsività, gli “oggetti desueti” del quotidiano (Orlando: 1993a). Contenitore delle idee che dà forma ai contenuti, l’immaginario traccia itinerari e mappe tra le culture, tra le pratiche discorsive, tra lingue e società diverse: la sua vocazione è quella di ricomporre le differenze e di dare cittadinanza letteraria ad una vasta congerie di sfumature e di temi. Con due regole, due meccanismi: uno di tipo archeologico, e qui il tema si riconfigura come archetipo, immagine e motore iniziale di una tradizione; il secondo di tipo genealogico, in cui il tema è “un processo, una sopravvivenza” che si colloca nello sviluppo di una traditio e la innerva, la irrobustisce, la determina anche qualitativamente nelle forme e nelle varianti (Giglioli: 2009). “Quando una mitologia si trasforma in letteratura, – scrive Northrop Frye – la funzione sociale di quest’ultima di fornire alla società una visione immaginaria della condizione umana, trova la sua origine diretta nel suo antenato mitologico. In seguito a tale processo le forme tipiche del mito divengono le convenzioni e i generi della letteratura, ed è solo quando le convenzioni e i generi sono riconosciuti come i caratteri essenziali della forma letteraria che il rapporto fra la letteratura e il mito si impone in quanto tale. L’età dell’oro mitica diviene allora una convenzione pastorale, i racconti mitici dell’irrimediabile decadenza della condizione umana forniscono le convenzioni dell’ironia, il sentimento mitico dello scarto fra la potenza divina e l’orgoglio umano diviene convenzione tragica, i miti eroici forniscono le convenzioni del romanzesco” (Frye: 1971, 497).
Proprio su questa curvatura tematica di una formazione all’immaginario sembrano positivamente convergere anche alcune significative tendenze della filosofia dell’educazione: esse hanno tra l’altro molti elementi in comune con il taglio antropologico e interdisciplinare di una parte della ricerca letteraria (Certini: 2004). In questo senso la pedagogia manifesta certamente una posizione di apertura dialettica nei confronti dei saperi letterari arricchendoli di quell’equipaggiamento riflessivo e metacognitivo che si rende necessario per tradurre istanze, finalità, categorie epistemiche in prassi formative e in azione didattica. Ma c’è forse di piú: la pedagogia ha svolto in questi ultimi decenni – non soltanto come riflessione teoretica, ma anche per una piú qualificata consapevolezza professionale del lavoro docente – un ruolo di segnavia metodologico dei saperi ponendosi come luogo di incontro e di discussione delle epistemologie disciplinari, come spazio di accoglienza e di ripartenza progettuale in vista di un nuovo inizio.